In questo splendido racconto, Varlam Shalamov racconta brevemente le condizioni di vita degli schiavi sovietici nei GuLag. Un racconto assolutamente da leggere (assieme a tutti gli altri "racconti di Kolyma" e Arcipelago Gulag) per chi ancora si dichiara comunista.
Il mullah tataro e la vita all’aria aperta - di Varlam Shalamov
I Racconti della Kolyma vol.1 pag. 103-114
Nella cella della prigione faceva così caldo che non si vedeva una mosca. Le enormi finestre con le grate di ferro erano completamente spalancate, ma questo non arrecava alcun sollievo perché dall’asfalto rovente del cortile arrivavano ondate d’aria calda e nella cella c’era persino più fresco che fuori.
Ci si era sbarazzati di tutti gli indumenti e centinaia di corpi nudi che sudavano esalando pesanti vapori si voltavano e rivoltavano sul pavimento — sopra i tavolacci a castello faceva troppo caldo. Ogni volta che il comandante faceva l’appello, i detenuti si mettevano in riga, vestiti con le sole mutande, restavano un’ora al gabinetto per i loro bisogni, annaffiandosi in continuazione con l’acqua fredda dei lavabi. Ma il sollievo non era duraturo. I podnarniki, quelli che per mancanza di posto erano sistemati per terra sotto i nary, i tavolacci, si erano ritrovati all’improvviso titolari dei posti migliori. Bisognava prepararsi a raggiungere «gli accampamenti lontani» e si scherzava, con il cupo umorismo della galera, dicendo che dopo la tortura del bagno di vapore ci sarebbe stata la tortura del congelamento.
Un mullah tataro, un detenuto sotto istruttoria per il famoso caso della «Grande Tataria», di cui noi eravamo già informati molto tempo prima che ne accennassero i giornali, un uomo solido e sanguigno di sessant’anni, con il petto possente coperto di peli grigi, e due occhi scuri e tondi dallo sguardo vivace, diceva, asciugandosi continuamente il cranio calvo e lucente con uno straccetto bagnato:
— Basta che non mi fucilino. Se mi appioppano dieci anni è una fesseria. Una pena del genere può far paura solo a chi conta di vivere fino a quarant’anni. Ma io conto di vivere fino agli ottanta.
Al ritorno dall’ora d’aria, il mullah saliva di corsa al quinto piano senza nessun affanno.
— Se me ne danno più di dieci, — continuava le sue riflessioni ad alta voce, — in prigione me la caverò lo stesso, fossero anche vent’anni, ma se è nel lager che mi mandano — il mullah tacque ...vita all’aperto, aria pura, allora dieci anni.
Questo mullah intelligente e sveglio mi è ritornato in mente oggi, rileggendo le Memorie di una casa morta. Il mullah sapeva cos’era «l’aria pura». Morozov e la Figner (due rivoluzionari incarcerati nelle prigioni zariste NDR) trascorsero vent’anni nella fortezza di Schlusselburg, con un regime carcerario severissimo e ne uscirono perfettamente in grado di lavorare. La Figner ebbe forze sufficienti per continuare ad occuparsi dell’attività rivoluzionaria e poi scrivere dieci volumi di memorie sugli orrori patiti, mentre Morozov pubblicò una serie di noti lavori scientifici e fece un matrimonio d’amore con una ginnasiale.
Nel lager, perché un uomo giovane e in buona salute — che ha iniziato la sua carriera sul fronte di taglio di un giacimento aurifero, in inverno, all’aria pura si trasformi in un dochodjaga, un morto che cammina, bastano da venti a trenta giorni di lavoro, con orari giornalieri di sedici ore, senza giorni di riposo, con una fame costante, gli abiti a brandelli e le notti passate sotto una tenda catramata piena di buchi mentre all’esterno la temperatura scende a meno sessanta gradi, con i pestaggi dei «caporali», degli starosta scelti tra i malavitosi, dei soldati della scorta. Sono termini ampiamente verificati. Le squadre che aprono la stagione aurifera e portano il nome del loro caposquadra, alla fine del periodo di scavo non hanno più neanche uno degli uomini presenti inizialmente, a parte il caposquadra stesso, il «piantone» responsabile della baracca e qualche amico personale del caposquadra. Gli altri elementi cambiano tutti, e più volte nel corso di una stagione. Il giacimento aurifero getta senza sosta le scorie umane della produzione negli ospedali, nelle cosiddette «squadre di ristabilimento», nei centri per invalidi e nelle fosse comuni.
La stagione aurifera comincia il 15 maggio e termina il 15 settembre, quattro mesi. Del lavoro in inverno è meglio non parlare.
All’inizio dell’estate le principali squadre dei fronti di taglio sono formate da gente nuova che non ha ancora passato un inverno nel lager. I detenuti condannati alla deportazione non vedevano l’ora di lasciare la prigione per il lager, dove, pensavano, li aspettava un lavoro, l’aria buona della campagna, i rilasci anticipati, la corrispondenza e i pacchi da casa, guadagni in contanti. L’uomo crede sempre nel meglio. Accanto alle fessure delle porte dei carri merci riscaldati che ci portavano verso l’Estremo Oriente sovietico, si accalcavano giorno e notte i detenuti in traduzione, aspiravano inebriati l’aria tranquilla della sera, un’aria fresca e impregnata dell’odore dei fiori di campo, che vorticava nella scia del treno. Quest’aria era ben diversa da quella viziata della cella, che sapeva di fenolo e di sudore umano, e che ci era diventata insopportabile nel corso dei lunghi mesi dell’istruttoria. In quelle celle lasciavamo il ricordo del nostro onore profanato e calpestato, qualcosa che si desidera solo dimenticare.
Per semplicità di spirito, i detenuti si immaginavano che il carcere e l’istruttoria fossero le prove più crudeli, visto che avevano sconvolto tanto brutalmente la loro esistenza. Per loro, era stato l’arresto il trauma morale più grave. E ora che si erano liberati della prigione, inconsciamente volevano credere nella libertà, una libertà certo relativa, ma libertà comunque, una vita senza le maledette inferriate, senza umilianti e oltraggiosi interrogatori. Per loro stava iniziando una nuova vita, senza quella perpetua tensione della volontà necessaria per affrontare gli interrogatori durante l’istruttoria. Sentivano un enorme sollievo all’idea che tutto fosse ormai irrevocabilmente deciso, la pena inflitta, e che non ci fosse più bisogno di pensare a cosa rispondere all’inquirente, né motivo di preoccuparsi per i propri cari, che fosse inutile fare progetti o combattere per un tozzo di pane: ormai essi erano nelle mani di una volontà esterna, ormai era impossibile cambiare alcunché, impossibile svoltare da quel scintillante tracciato ferroviario che li portava lentamente ma inesorabilmente verso il Nord.
Il treno andava incontro all’inverno. Ogni notte era più fredda da della precedente e le foglie verdi e succose dei pioppi erano già intaccate da vivide screziature gialle. Il sole non era più cosi caldo e splendente, come se le foglie degli aceri e dei pioppi, delle betulle e dei tremoli si fossero imbevute, impregnate della sua forza dorata. Le foglie stesse ora risplendevano di luce solare. E il sole stesso, pallido, esangue, non riusciva più neanche a riscaldare il vagone, nascondendosi per la maggior parte del giorno dietro a calde nuvole grigioazzurre che ancora non sapevano di neve. Ma la neve, comunque, non si sarebbe fatta attendere a lungo.
Un centro di smistamento e ancora un’altra tratta in direzione nord. L’insenatura marina li accolse con una piccola tempesta di neve. La neve ancora non si fermava — il vento la spazzava dai dirupati pendii di rocce giallastre e ghiacciate, spingendola dentro buche dalle acque torbide e sporche. La cortina della tempesta era trasparente. Una nevicata rada, simile a una rete da pesca di fili bianchi gettata sull’abitato. Sul mare la neve non era visibile: onde increspate di colore verde scuro si frangevano lentamente contro la rupe scivolosa e verdastra. Il piroscafo era in rada e visto dall’alto sembrava minuscolo come un giocattolo, ma anche quando raggiunsero in motoscafo la fiancata e uno dopo l’altro si issarono sul ponte, per disperdersi subito dopo inghiottiti dai boccaporti delle stive, il piroscafo si rivelò stranamente piccolo, circondato com’era da così tanta acqua. Dopo cinque giorni e cinque notti vennero sbarcati su una riva fredda e cupa della tajga e alcuni autocarri li trasportarono là dove ormai avrebbero dovuto vivere — e sopravvivere.
L’aria buona della campagna l’avevano lasciata al di là del mare. Qui erano immersi nell’aria rarefatta della tajga, impregnata delle esalazioni delle paludi. I rilievi dalle cime arrotondate erano coperti di vegetazione palustre e solo le calve sommità prive di boschi rilucevano del calcare nudo e levigato da venti e tempeste. Si affondava in un muschio melmoso, d’estate capitava raramente di avere i piedi all’asciutto. D’inverno tutto gelava. Il gelo sembrava rapprendere ogni cosa — le montagne, i fiumi, la palude — in un’unica massa, sinistra e ostile.
L’aria che già in estate creava problemi ai cardiopatici, d’inverno diventava insopportabile. Durante i grandi freddi la respirazione si faceva affannosa, Qui nessuno correva mai, salvo forse i più giovani, ma anch’essi più che correre sembravano saltellare. Nugoli di zanzare si incollavano al viso - non sì poteva fare un passo senza la rete di garza. Ma sul lavoro la garza soffocava, impediva di respirare. E tuttavia non si poteva toglierla per via delle zanzare.
Allora si lavorava sedici ore al giorno e le norme lavorative erano calcolate su questa base. Se si considera che la levata, la colazione, l’avvicendamento delle squadre e il tempo di arrivare sul posto di lavoro prendevano come minimo un’ora e mezza, il pasto di mezzogiorno un’ora e quello serale con l’appello, un’altra ora e mezza, non restavano più di quattro ore di sonno dopo un estenuante lavoro fisico all’aria aperta. Ognuno si addormentava nell’istante stesso in cui smetteva di muoversi, qualcuno arrivava ad addormentarsi in piedi o mentre camminava. L’insufficiente riposo debilitava ancor più della fame. Se non si realizzava la norma c’era la razione punitiva: trecento grammi di pane al giorno e niente sbobba. La prima illusione svanì molto rapidamente. Era quella riguardante il lavoro, quel famoso lavoro di cui parla la celebre iscrizione, prevista dal regolamento dei lager, che è appesa sull’entrata di ogni stabilimento concentrazionario. «Il lavoro è una questione d’onore, una questione di gloria, una questione di valore e di eroismo». Ma il lager poteva solo inculcare, e di fatto inculcava, odio e disgusto per il lavoro.
Una volta al mese il postino del lager portava all’ufficio censura tutta la posta che si era accumulata. Le lettere dirette al «continente» o da esso provenienti ci mettevano sei mesi ad arrivare a destinazione, se mai arrivavano. I pacchi da casa erano consegnati solo a coloro che realizzavano la norma, agli altri venivano requisiti. Tutto questo non rivestiva un carattere di arbitrarietà, tutt’altro. Alla gente veniva data lettura di specifiche disposizioni al riguardo, e in certi casi particolarmente importanti si obbligava l’interessato ad apporre la propria firma. Non si trattava della malvagia fantasia di qualche degenerato dirigente periferico: era un ordine delle autorità superiori.
Ma se anche qualcuno riceveva il proprio pacco — si doveva sempre prometterne la metà a qualche sorvegliante e ottenerne in cambio almeno la parte restante —, non sapeva poi dove portarlo. Alla baracca i malavitosi lo stavano già aspettando da un pezzo per prenderglielo sotto gli occhi di tutti e dividerselo con i loro smorfiosi Vaneèka o Seneèka. L’alternativa era: o mangiarsi immediatamente tutti i commestibili del pacco o venderli. Di compratori ce n’erano a bizzeffe: «caporali», autorità varie, medici.
Esisteva una terza via d’uscita, la più praticata. Molti detenuti affidavano i loro pacchi, perché li conservassero, a persone conosciute nel lager o in prigione, che avevano incarichi o svolgevano lavori tali da consentire loro di nascondere o mettere sotto chiave qualcosa. Oppure li davano a qualcuno dei salariati esterni. Sia nell’uno che nell’altro caso si doveva correre qualche rischio — nessuno credeva nell’onestà dei depositari —, ma questa era l’unica possibilità di salvare il pacco ricevuto.
Soldi non ne versavano. Neanche un centesimo. Pagavano solo le squadre migliori, e anche in quel caso somme irrisorie che non potevano essere minimamente d’aiuto. In molte squadre, i capi- squadra procedevano in questo modo: il guadagno dell’intera squadra lo assegnavano a due o tre persone, attribuendo loro un rendimento superiore alla norma, il che comportava per l’appunto un premio in denaro. Gli altri venti o trenta componenti della squadra si prendevano la loro razione di rigore per scarso rendimento. Era una soluzione brillante. A dividere equamente il rendimento tra tutti, nessuno avrebbe preso un soldo. In questo modo, invece, ricevevano del denaro due o tre persone, scelte del tutto casualmente e spesso perfino senza che il caposquadra partecipasse alla stesura dell’elenco.
Tutti sapevano che le norme erano irrealizzabili, che non c’era né ci poteva essere un salario, ma questo non impediva a certuni di star dietro ai caporali, di interessarsi della produttività, di affrettarsi incontro al cassiere, di andare all’ufficio a chiedere informazioni. Che cos’era? Forse il desiderio di farsi passare a tutti i costi per un rabotjaga, un gran lavoratore, di innalzare la propria reputazione agli occhi della direzione, o semplicemente una sorta di disturbo psichico dovuto all’alimentazione carente? Quest’ultima ipotesi mi sembra la più giusta.
Vista da quaggiù, la prigione occupata durante il procedimento istruttorio, la cella luminosa, pulita e calda che avevano lasciato così di recente, e tuttavia da una tale eternità, sembrava a tutti, a tutti senza eccezione, il miglior luogo della terra. Gli oltraggi subiti in quel luogo erano completamente dimenticati e tutti ricordavano con trasporto come là si potessero ascoltare lezioni di veri e propri eruditi di passaggio e racconti di persone navigate; e i libri letti, e i magnifici bagni della prigione, e come si dormisse a sufficienza e si mangiasse a sazietà, e come fosse possibile ricevere pacchi da casa e sentire la presenza dei familiari proprio li accanto, dietro la doppia barriera metallica del portone; e come si parlasse liberamente, di tutto quello che passava per la mente (nel lager questo comportava un periodo di pena supplementare), senza dover temere né spie né sorveglianti. La prigione del procedimento istruttorio sembrava loro perfino più libera e familiare della propria casa, e non c’era detenuto che, abbandonandosi alle fantasticherie in un lettino d’ospedale, non dicesse, anche se magari gli restava poco da vivere: « Mi piacerebbe, naturalmente, riveder la mia famiglia, andarmene di qui. Ma ancora di più mi piacerebbe ritornare nella mia cella della prigione durante l’istruttoria vi si stava meglio ed era più interessante che a casa. E adesso potrei anche raccontare a tutti i novellini che cos’è in realtà questa famosa “vita all’aria aperta”».
Per non aggiungere a tutto questo lo scorbuto quasi generalizzato che assumeva, come ai tempi di Bering, le minacciose proporzioni di una dilagante epidemia con migliaia di vittime; e la dissenteria causata dal fatto che mangiavamo tutto ciò che ci capitava sottomano, pensando solo a riempirci lo stomaco dolorosamente roso dalla fame, raccogliendo, per placarla, gli avanzi di cucina da mucchi di immondizie fittamente coperti di mosche; e la pellagra, la malattia degli indigenti, il deperimento totale, in seguito alla quale la pelle si sfila come un guanto dalle palme delle mani e dalle piante dei piedi, e si desquama da tutto il corpo in grossi petali tondeggianti simili a impronte digitali; e, infine, la ben nota distrofia alimentare, la malattia degli affamati che soltanto dopo l’assedio di Leningrado hanno cominciato a chiamare con il suo vero nome. Fino ad allora aveva ricevuto varie denominazioni Rfi, le misteriose iniziali che comparivano nelle cartelle cliniche, e stavano per "esaurimento fisico acuto", o, più frequentemente poliavitamiosi, un affascinante nome latino che indica la carenza di alcune vitamine nell’organismo umano e tranquillizza i medici, che hanno così trovato una formula latina appropriata e legale per designare sempre la stessa cosa — la fame.
Se si aggiungono le baracche umide e prive di riscaldamento, all’interno delle quali spessi strati di ghiaccio gelavano dentro ogni fessura come se stesse gocciolando in un angolo un’enorme candela di stearina... Vestiti scadenti e razioni da fame, congelamenti - e un congelamento significa sofferenze, se non amputazioni, che durano per sempre. Se si pensa alla quantità di influenze, polmoniti, raffreddori d’ogni tipo, tubercolosi che dovevano manifestarsi e si manifestavano tra quelle alture paludose, deleterie per i cardiopatici. Se si ricordano le epidemie di automutilazioni, di autoamputazioni. Se si tiene inoltre nel debito conto l’immensa prostrazione morale e l’assenza di qualsivoglia speranza, si vede facilmente fino a qual punto l’aria aperta fosse per la salute dell’uomo più pericolosa della prigione.
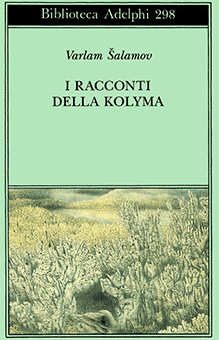
Varlam Shalamov - I Racconti della Kolyma Volume primo pagine 103 - 114. Edizione Einaudi. Traduzione di Sergio Rapetti.









